
 |
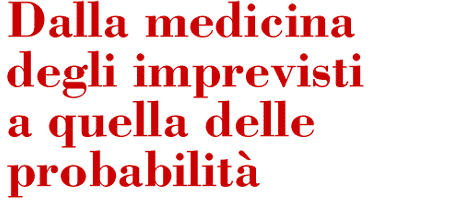 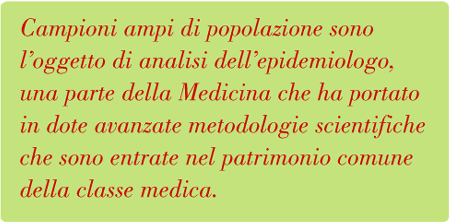 |
| Paolo Vineis ha una doppia vita e non solo perché insegna sia all'Imperial College di Londra dove ha la cattedra di Epidemiologia ambientale sia Biostatistica all'università di Torino. La sua doppia vita lo vede essere tra i maggiori esperti mondiali di epidemiologia oncologica (soprattutto nel rapporto fra i fattori ambientali e la mutazione genetica nello sviluppo dei tumori) ma è anche impegnato nella riflessione filosofica (ha scritto libri e articoli sul concetto di causa in medicina) e politica (ha al suo attivo diversi libri sul ruolo dei servizi sanitari nazionali ed è stato consulente del PM nel processo alla Enimont di Porto Marghera). Su un fronte e sull'altro ha pubblicato 8 libri, (Vuoi leggere l'elenco dei libri disponibili in italiano? Clicca qui) e 200 articoli scientifici, è stato due volte presidente della Societa Italiana di Epidemiologia ed è docente alla Columbia university. |
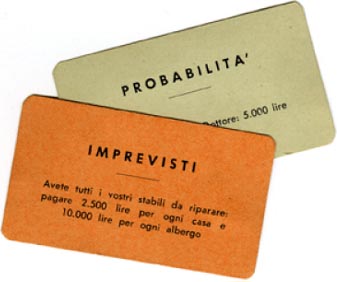 Una volta la Medicina era fatta di 'sì' e di 'no', insieme a qualche 'non
sappiamo'. Oggi i concetti di probabilità e di rischio sono entrato nel modo di
ragionare di tutti i medici a ogni livello. Che ruolo ha avuto l'epidemiologia
in questo sviluppo?
L'epidemiologia è stata centrale in questo passaggio. In almeno due modi:
attraverso lo sviluppo degli studi sulle 'cause' delle malattie, e contribuendo
a definire delle 'regole' che permettono di dire se i risultati di una ricerca,
per esempio la sperimentazione di un farmaco, sono validi e anche quanto lo
sono. Negli anni '30 un trattamento veniva prescritto perché il professor Tizio
aveva trovato, in una piccola serie di pazienti, risultati superiori a quelli
del professor Caio. In questo modo una malattia poteva avere decine di terapie
diverse. Solo alla fine degli anni '40 venne introdotta l'idea di un confronto
sistematico fra pazienti, di cui un gruppo veniva trattato con il farmaco da
sperimentare e l'altro gruppo con un placebo e i membri dell'uno e dell'altro
gruppo venivano scelti a caso.
Non c'è un contrasto insanabile fra la statistica (che si basa su
campioni ampi) e la cura dove sono in gioco un medico e soprattutto un paziente?
Come risolverlo concettualmente?
Sono d'accordo: per il medico il trasferimento dei risultati delle
sperimentazioni randomizzate al singolo paziente è estremamente difficile. Però
è proprio applicando in maniera severa concetti nati nell'epidemiologia che oggi
è possibile definire l'efficacia di alcune prassi mediche.
L'epidemiologia rischia di essere l'arma attraverso la quale un
sistema sanitario nazionale con risorse sempre più scarse nega l'accesso a certe
cure. Considerazioni statistiche vengono fatte episodicamente a sostegno di
alcune scelte e non di altre. È d'accordo?
In Inghilterra il NICE e altre istituzioni cercano di basare le proprie
scelte sulle migliori prove esistenti, secondo i principi della Evidence Based
Medicine. Il problema è che non solo spesso mancano le informazioni cliniche
pertinenti, ma mancano anche le informazioni economiche o politiche per
permettere una decisione soddisfacente in circostanze complesse. Spesso si
sottovaluta il fatto che alcuni valori (la qualità della vita, per esempio) non
sono facilmente quantificabili e che variano enormemente da una persona
all'altra, con implicazioni etiche non indifferenti.
Chi rischia non è né al sicuro né in pericolo. In medicina chi ha un
fattore di rischio non è né sano né malato. Siamo quasi tutti o tutti in una
condizione di salute più o meno sufficiente. È così?
Penso che effettivamente sia così: il nostro corpo ha in ogni momento un
numero elevatissimo di cellule che veicolano mutazioni genetiche (per esempio
nella pelle per l'azione dei raggi solari). La distinzione tra sano e malato
sembra più una questione di gradi che una dicotomia. Questo ha implicazioni
filosofiche e pratiche profonde. Per esempio, un eccesso di screening potrebbe
non giovare concretamentre al paziente, visto che qualche alterazione è molto
probabile che la troveremo.
Dal concetto di salute sufficiente e di malattia cronica discende
anche il fatto che il medico, sempre più spesso, 'cura' ma non 'guarisce'. Come
è colto questo dal mondo della sanità?
Mi pare che la nostra socità stia ancora metabolizzando i grandi
mutamenti originati dall'introduzione del metodo statistico, e delle filosofie
di cura che ne dericano. Dallo sviluppo clamoroso delle tecniche di diagnosi e
di medicina predittiva aI confini più sfumati tra malattia e salute, tra
malattia cronica e cronicità.
Una volta la Medicina era fatta di 'sì' e di 'no', insieme a qualche 'non
sappiamo'. Oggi i concetti di probabilità e di rischio sono entrato nel modo di
ragionare di tutti i medici a ogni livello. Che ruolo ha avuto l'epidemiologia
in questo sviluppo?
L'epidemiologia è stata centrale in questo passaggio. In almeno due modi:
attraverso lo sviluppo degli studi sulle 'cause' delle malattie, e contribuendo
a definire delle 'regole' che permettono di dire se i risultati di una ricerca,
per esempio la sperimentazione di un farmaco, sono validi e anche quanto lo
sono. Negli anni '30 un trattamento veniva prescritto perché il professor Tizio
aveva trovato, in una piccola serie di pazienti, risultati superiori a quelli
del professor Caio. In questo modo una malattia poteva avere decine di terapie
diverse. Solo alla fine degli anni '40 venne introdotta l'idea di un confronto
sistematico fra pazienti, di cui un gruppo veniva trattato con il farmaco da
sperimentare e l'altro gruppo con un placebo e i membri dell'uno e dell'altro
gruppo venivano scelti a caso.
Non c'è un contrasto insanabile fra la statistica (che si basa su
campioni ampi) e la cura dove sono in gioco un medico e soprattutto un paziente?
Come risolverlo concettualmente?
Sono d'accordo: per il medico il trasferimento dei risultati delle
sperimentazioni randomizzate al singolo paziente è estremamente difficile. Però
è proprio applicando in maniera severa concetti nati nell'epidemiologia che oggi
è possibile definire l'efficacia di alcune prassi mediche.
L'epidemiologia rischia di essere l'arma attraverso la quale un
sistema sanitario nazionale con risorse sempre più scarse nega l'accesso a certe
cure. Considerazioni statistiche vengono fatte episodicamente a sostegno di
alcune scelte e non di altre. È d'accordo?
In Inghilterra il NICE e altre istituzioni cercano di basare le proprie
scelte sulle migliori prove esistenti, secondo i principi della Evidence Based
Medicine. Il problema è che non solo spesso mancano le informazioni cliniche
pertinenti, ma mancano anche le informazioni economiche o politiche per
permettere una decisione soddisfacente in circostanze complesse. Spesso si
sottovaluta il fatto che alcuni valori (la qualità della vita, per esempio) non
sono facilmente quantificabili e che variano enormemente da una persona
all'altra, con implicazioni etiche non indifferenti.
Chi rischia non è né al sicuro né in pericolo. In medicina chi ha un
fattore di rischio non è né sano né malato. Siamo quasi tutti o tutti in una
condizione di salute più o meno sufficiente. È così?
Penso che effettivamente sia così: il nostro corpo ha in ogni momento un
numero elevatissimo di cellule che veicolano mutazioni genetiche (per esempio
nella pelle per l'azione dei raggi solari). La distinzione tra sano e malato
sembra più una questione di gradi che una dicotomia. Questo ha implicazioni
filosofiche e pratiche profonde. Per esempio, un eccesso di screening potrebbe
non giovare concretamentre al paziente, visto che qualche alterazione è molto
probabile che la troveremo.
Dal concetto di salute sufficiente e di malattia cronica discende
anche il fatto che il medico, sempre più spesso, 'cura' ma non 'guarisce'. Come
è colto questo dal mondo della sanità?
Mi pare che la nostra socità stia ancora metabolizzando i grandi
mutamenti originati dall'introduzione del metodo statistico, e delle filosofie
di cura che ne dericano. Dallo sviluppo clamoroso delle tecniche di diagnosi e
di medicina predittiva aI confini più sfumati tra malattia e salute, tra
malattia cronica e cronicità.
Libri di Paolo Vineis in italiano Elementi di economia sanitaria Dirindin Nerina; Vineis Paolo; Il Mulino 2004 In buona salute. Dieci argomenti per difendere la sanità pubblica, Vineis Paolo; Dirindin Nerina ; Einaudi 2004 Etica, ambiente e biotecnologie. Un manuale Vineis Paolo; Il Pensiero Scientifico 2003 Nel crepuscolo della probabilità. La medicina tra scienza ed etica, Vineis Paolo; Einaudi 1999 La salute non è una merce. Efficacia della medicina e politiche sanitarie, Vineis Paolo - Capri Stefano; Bollati Boringhieri 1994 L'osservazione medica. Dalla diagnosi precoce alle cause ambientali delle malattie: i nuovi temi della medicina, Vineis Paolo; Garzanti Libri 1991 Manuale di metodologia epidemiologica Vineis Paolo; Duca Piergiorgio; Pasquini Paolo; Carocci 1988