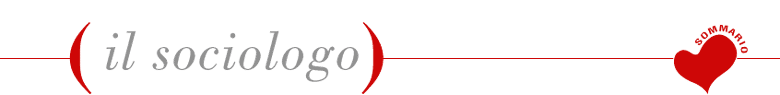
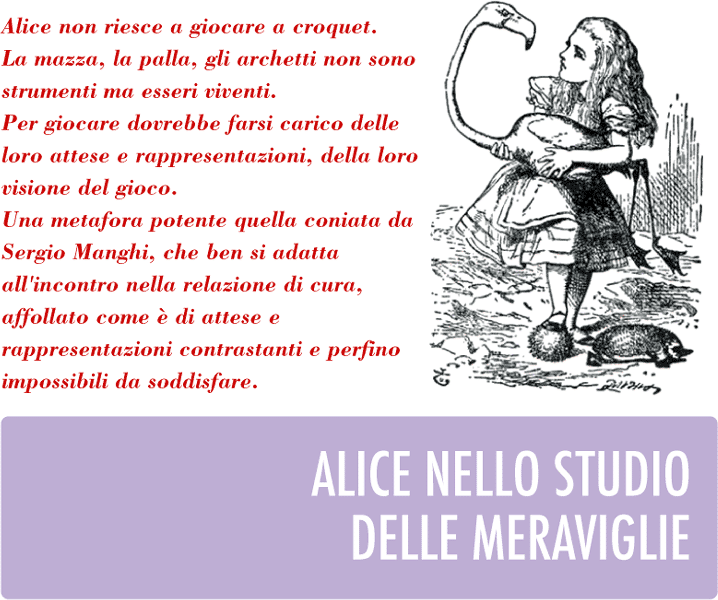
Nel magico libro di Lewis Carroll Alice viene invitata a una partita di croquet. Alice accetta perché conosce bene le regole del gioco. Si tratta - un po' come nel golf - di spingere con una pallina con la mazza sotto degli archetti piantati nel terreno. Semplice e cartesiano.
Ma la partita si rivela difficile. Gli strumenti non sono tali ma sono esseri viventi: la mazza è un fenicottero, la palla un porcospino, gli archetti sono formati da soldati-carte da gioco. «Ciascuno ha una sua immagine di quello che sta avvenendo, e queste immagini creano attese di ciò che sta per avvenire, producono attivamente comportamenti», spiega Sergio Manghi. L'interazione comunicativa è un 'play', una interrelazione creativa, non un 'game' nel quale esistono regole e strumenti passivi. Per giocare Alice dovrebbe 'farsi carico', prendersi cura di tutti gli attori del gioco e tenere ben presenti le loro rappresentazioni.
Sergio Manghi, vede in questo passo di Alice nel paese delle meraviglie una metafora di ogni relazione umana e così la propone in La conoscenza ecologica (Raffaello Cortina editore 2004). A maggior ragione la potente metafora si attaglia all'incontro che avviene nella relazione di cura.
A questo specifico tema Manghi, docente di Sociologia della conoscenza al Dipartimento di studi politici e sociali dell'università di Parma ha dedicato una recente parte della sua attività di studio.
Ha coordinato per l'ateneo parmense il progetto di ricerca nazionale Le trasformazioni del sapere medico, ed è autore di Il medico, il paziente e l'altro (Franco Angeli 2005) che riporta una parte dei risultati della ricerca. «In questo studio abbiamo intervistato 55 medici ospedalieri e di base», riferisce Manghi che è uno dei massimi studiosi italiani del pensiero di Gregory Bateson, «cercando di individuare le immagini che loro hanno dell'interazione con il paziente».
Perché i medici e perché indagare sulle loro immagini?
I medici perché dopo decenni in cui i ruoli sono rimasti piuttosto stabili, questo tipo di 'agenzia sociale' è sottoposta a una rapida trasformazione: pensiamo alla aziendalizzazione del sistema sanitario, alla specializzazione, alla maggiore informazione e 'contrattualità' del paziente. Le immagini perché ognuno, anche il medico, ha una immagine di quello che sta accadendo mentre interagisce, un'immagine della quale è in larga misura inconsapevole, ma che produce azione, momento per momento. Non si può sospendere l'azione, non si può non comunicare, e l'immagine che uno ha di quello che accade mentre comunica concorre attivamente a fare l'intreccio comunicativo di cui è parte. Allora ci siamo chiesti: Quali sono le immagini che i medici hanno, ma dovremmo dire: che agiscono, di quello che accade - a loro e all'interlocutore - mentre comunicano?
Quanto sono importanti queste immagini?
Non sono tutto, perché all'interazione concorrono ovviamente anche immagini e comportamenti altrui. Ma contano molto. Perché non sono semplici fotografie ma forme viventi: svolgono una azione: creano attese e modi di agire. Sono motori del cambiamento - o del mancato cambiamento. L'evoluzione sociale, organizzativa e comunicativa oggi in corso mina la validità delle immagini con cui i medici sono cresciuti. O forse è meglio dire di una parte, per quanto molto ampia, dei medici perché nella nostra inchiesta le immagini del medico dei reparti chirurgici, per esempio, sono parse meno sfidate a un cambiamento di quelle del medico di medicina generale.
Oggi non è facile dire come è fatto un 'buon medico'...
Se per quello nemmeno è facile dire come è fatto un buon paziente. Perché lo studio del medico è piuttosto affollato. C'è l'immagine del buon medico e del buon paziente agli occhi del medico, che non sempre collima con l'immagine che il paziente ha di un buon medico o di un buon paziente. Ma l'importante è sapere che le immagini che contano di più non sono tanto quelle dichiarate e ideali, piene di buoni propositi da entrambe le parti, quanto quelle concretamente agite, assorbite respirando le interazioni sociali di tutta la propria vita e riproposte inconsapevolmente nel qui e ora della comunicazione.
Arriveremo a una sintesi?
La nostra indagine ha disegnato la situazione vista con gli occhi del medico. Sarebbe molto interessante indagare anche quelle del paziente, e se troveremo le risorse lo faremo. Io credo che le immagini del medico e quelle del paziente si formino insieme, le une attraverso le altre, e dunque mi aspetterei di trovare sia analogie sia differenze, ma sempre interconnesse. Per esempio, quando i medici dicono che oggi i pazienti vivono come se fosse possibile, anzi normale, non ammalarsi, che i successi della Medicina e l'allontanamento anche fisico della morte e della malattia hanno creato una immagine della salute che fa a meno del suo orizzonte di malattia e di mortalità, mi aspetterei di trovare conferme di questo nell'immagine che i pazienti hanno della salute.
E questa è una evoluzione recente...
Io direi che negli ultimi 20 anni è avvenuta un'evoluzione epocale: siamo passati dall'attesa che la medicina curi la malattia, all'attesa che la vita non finisca mai. Misuriamo il tempo come un eterno presente di benessere. È sempre oggi. A questo punto la 'domanda' non è più di salute ma di immortalità.
Ma nessun medico può garantire l'immortalità.
Eppure è questo che in fondo il 'cliente' chiede molto spesso. La domanda non può che essere disattesa. Il professionista è per definizione insufficiente. Il suo sapere è delegittimato. Ma facciamo attenzione: questo vale se il medico si identifica solo con il sapere strettamente biomedico. Sul piano del sapere delle relazioni, quello che noi abbiamo indagato, si aprono invece nuove sfide e possibilità. Su questo piano, la domanda di immortalità non può essere disattesa.
Non per risponderle letteralmente, beninteso, come vorrebbe la cultura strettamente biomedica. Ma porsi in ascolto di quella domanda, saper prendere in carico la salute del paziente intesa in modo più ampio, è una sfida che non può essere elusa.
E come reagisce a questo il medico? Con frustrazione?
Spesso sì, perché i saperi relazionali ereditati dal passato sono insufficienti. Accade anche di reagire non stando più al gioco e non accompagnando più il paziente. Il chirurgo, per esempio, tende spesso a parcellizzare la sua prestazione. Il singolo medico e il sistema sanitario, persona e istituzione, reagiscono all'unisono. Io penso a questo atto di cura, non rispondo del processo, dicono ambedue. Il prendersi cura si rannicchia nella prestazione ben fatta. Ma sono molti i medici che, anche con fatica crescente, si sentono impegnati a cercare nuovi saperi relazionali, a prender parte ai processi di cura nel loro insieme.
Questo avviene solo nella Medicina?
No. un fenomeno speculare lo vediamo anche nella formazione dei giovani. Se il presente è eterno non solo non ha fine, ma non ha nemmeno mai inizio. È delegittimata l'idea stessa di poter accompagnare un giovane nella crescita. Per questo l'insegnante si rifugia spesso in un sapere tecnico. Magari stando attento a non deludere la famiglia. La presa in carico emotiva è anche qui spezzettata. Da un mondo di Guide stiamo forse approdando a un mondo di Consulenti.
E allora?
Quando ci interroghiamo sui tanti costi della sanità, dobbiamo ricordare che questi costi, siano essi in termini di eccesso di cure di duplicazione di interventi, di mancanza di coordinamento sono i costi di questa infelicità collettiva. E anche di legittimi desideri di felicità. Occorrerebbe riformare l'idea stessa di Sanità, lasciarsi alle spalle il primato del sapere biomedico e porre al centro un'idea di salute più ampia. Le competenze biomediche ne risulterebbero insieme più circoscritte e più valorizzate.
La soluzione?
Io credo che sviluppare la capacità di presa in carico sia la risposta che una politica di formazione del personale sanitario deve dare. Una presa in carico relazionale, sociale, istituzionale, ancor prima che biotecnica.
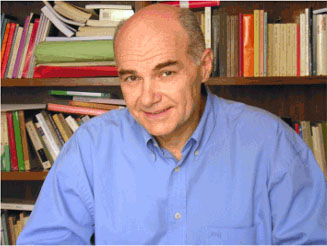 I Diabetologi sono arrivati a conclusioni simili, trovando proprio nella presa in carico, nell'accompagnamento e nei percorsi diagnostico terapeutici il terreno ideale su cui agire per far fronte alla cronicità.
I Diabetologi sono arrivati a conclusioni simili, trovando proprio nella presa in carico, nell'accompagnamento e nei percorsi diagnostico terapeutici il terreno ideale su cui agire per far fronte alla cronicità.
Ne sono felice e non mi stupisce. Abbiamo rilevato qualcosa di simile in vari medici di medicina generale, ma anche in alcuni chirurghi. Tutto sommato potremmo dire che è venuta a mancare una rappresentazione condivisa della cronicità E avere a che fare soprattutto con la cronicità, porta a una immagine di quel che sta accadendo, della complessità del processi di presa in carico, più adeguata e quindi a una autonomia anche concettuale. Attenzione però a un limite intrinseco ai percorsi standardizzati...
E cioè?
Ogni interazione tende ad avere una sua storia, una sua unicità, mantiene delle differenze che non sono irrilevanti. Occorre apprendere a riconoscere la molteplicità, saperci adattare all'imprevedibile, laddove la formazione del medico - anche quando disegna percorsi personalizzati - si basa ancora molto spesso su aspettative standard. Alla Medicina delle medie e della statistica bisogna accompagnare una Medicina della dell'evento e della sorpresa.
Dopotutto, le belle sorprese sono sempre la miglior gratificazione per ogni professionista...
Sergio Manghi
maggior studioso e interprete italiano del pensiero di Gregory Bateson, insegna Sociologia della Conoscenza all'Università di Parma ed è fra i docenti del Corso di perfezionamento in Psicologia ospedaliera dell'università di Parma. È tra i coordinatori del progetto di ricerca Le trasformazioni del sapere medico, parte del quale è stato pubblicato nel libro Il medico, il paziente e l'altro.