
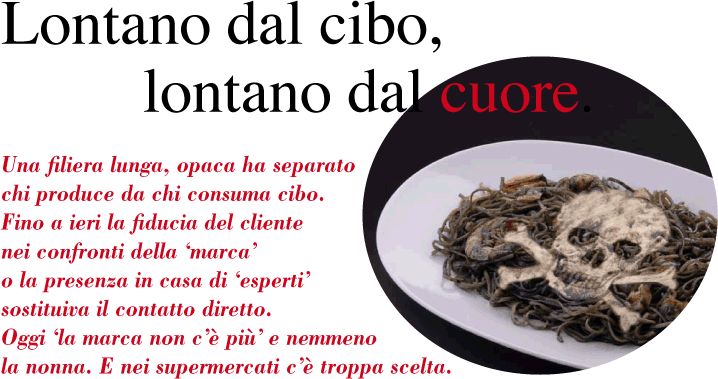
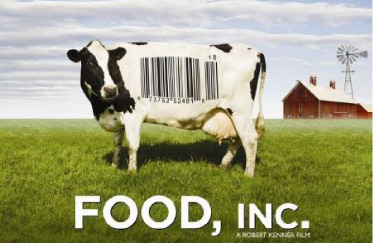 Probabilmente per la prima volta nella sua storia, oggi l'uomo ha paura di ciò che mangia. Ogni società ha sempre avuto i suoi tabù alimentari, ma sempre circoscritti a determinati alimenti e per motivi o religiosi (per piacere al proprio dio) o sanitari (per proteggere la propria salute) o, infine, per motivi 'simbolici' (per evitare conseguenze dannose nella propria vita o per donare qualcosa di buono al proprio corpo o genericamente a se stessi). Oggi si fa strada, soprattutto nei Paesi più avanzati e nelle classi socio culturali più alte, un senso di inquietudine nei confronti di tutti i cibi o della maggior parte di loro.
Probabilmente per la prima volta nella sua storia, oggi l'uomo ha paura di ciò che mangia. Ogni società ha sempre avuto i suoi tabù alimentari, ma sempre circoscritti a determinati alimenti e per motivi o religiosi (per piacere al proprio dio) o sanitari (per proteggere la propria salute) o, infine, per motivi 'simbolici' (per evitare conseguenze dannose nella propria vita o per donare qualcosa di buono al proprio corpo o genericamente a se stessi). Oggi si fa strada, soprattutto nei Paesi più avanzati e nelle classi socio culturali più alte, un senso di inquietudine nei confronti di tutti i cibi o della maggior parte di loro.
Si moltiplicano le informazioni su nuove allergie e intolleranze al cibo, spesso non diagnosticabili con i consueti mezzi diagnostici a cui fa riscontro un comportamento di avidi consumatori di ogni notizia che lega un alimento a un disturbo.
Carlo Cannella è Direttore dell'Istituto di Scienza dell'Alimentazione e della Scuola di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione all'università La Sapienza di Roma nonché presidente dell'Istituto nazionale di ricerca sugli alimenti e la nutrizione ha quindi due 'vesti' per rispondere alle nostre domande.
Il timore nei confronti di ciò che mangiamo si è sviluppato negli ultimi anni. Eppure in questi anni, per effetto delle legislazioni europee, della pressione dei consumatori e per la stessa concentrazione dei produttori in poche grandi realtà produttive e distributive, i rischi reali sono andati riducendosi. Perché abbiamo paura oggi?
In sintesi la risposta è: abbiamo troppa scelta e troppo poca conoscenza. Oggi, il consumatore è lontano dal luogo di produzione. Chi ha mai visto una stalla, un campo, un contadino?
Infatti oggi trovano molto interesse tutte le iniziative tese a riavvicinare consumatore e produttore, l'idea di consumare soprattutto cibi e vini del territorio, l'acquisto diretto da parte di gruppi di famiglie, la conoscenza e la difesa di produzioni locali e tradizioni antiche...
Certamente, sono segni di disagio e di risposta a una situazione che vede il consumatore lontano, e allontanato dalla produzione alimentare da filiere alimentari complesse che si estendono nel globo e comportano l'uso di tecnologie sempre maggiori e il consumatore reagisce con timore, ha la sensazione che questa catena tolga valore e aggiunga rischi.
Esistono questi rischi?
No, sono limitati, sempre più limitati. Ogni giorno mangiamo due chili di alimenti, se consideriamo le confezioni e le parti scartate, per 50 milioni di italiani fa 100 mila tonnellate che arrivano al consumatore. I casi in cui nella filiera si sono inseriti degli elementi di rischio riguardano una percentuale minima, infima. La grande distribuzione organizzata, i supermercati insomma, giocano un ruolo attivo a difesa del consumatore.
 Per quale ragione?
Per quale ragione?
Per il loro interesse. Sa quando avvenne il primo sciopero della storia? Fra i lavoratori che in quasi schiavitù costruivano le piramidi. E sa perché? Non per le terribili condizioni in cui lavoravano ma perché venne portata loro della birra avariata. La qualità è aumentata ma è venuta a mancare la fiducia. Negli anni '60 i caroselli dicevano Galbani vuol dire fiducia. E i grandi marchi, direi l'intera industria agroalimentare, la ottenne questa fiducia. Oggi c'è un clima di sospetto.
 Ma non è da oggi che il consumatore è allontanato dai luoghi di produzione. Ormai da un secolo una parte importante della popolazione vive in città...
Ma non è da oggi che il consumatore è allontanato dai luoghi di produzione. Ormai da un secolo una parte importante della popolazione vive in città...
Sì, ma fino a ieri c'era la nonna che sapeva scegliere, cucinare e servire in tavola. Oggi la nonna non c'è più e allora le aziende fanno di tutto per riprendere questa confidenza. Pensiamo a un imprenditore come Rana che appare in video in prima persona per garantire la sua pasta fresca.
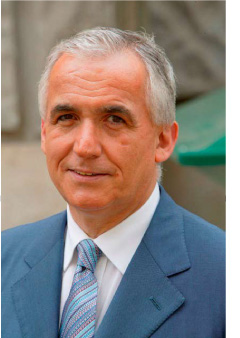 È vero: nelle loro campagne pubblicitarie molti marchi 'mettono in scena' la loro filiera, cercando di renderla trasparente facendo vedere i contadini che forniscono le aziende, gli stessi loro lavoratori come ha fatto Barilla...
È vero: nelle loro campagne pubblicitarie molti marchi 'mettono in scena' la loro filiera, cercando di renderla trasparente facendo vedere i contadini che forniscono le aziende, gli stessi loro lavoratori come ha fatto Barilla...
Esatto, ma forse non basta, occorre davvero ricucire la frattura, ridurre la distanza fra consumatore e produttore, anche se questo significa ridiscutere il ruolo di una serie di intermediazioni che contribuiscono fra l'altro a moltiplicare la differenza fra i prezzi alla produzione e al consumo. E poi bisogna chiedersi se non è la stessa ampiezza della scelta a disorientare il consumatore. I produttori hanno aumentato a dismisura l'offerta e ora c'è davvero l'imbarazzo e perfino il fastidio della scelta: davvero abbiamo bisogno di 200 tipi diversi di yogurt?
Carlo Cannella
Professore ordinario di Scienza dell'Alimentazione nella Ia Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università "La Sapienza" di Roma ove è Direttore dell'Istituto di Scienza dell'Alimentazione e della Scuola di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione; Presidente del Corso di Laurea di "Dietista" nella sede sussidiata dell'Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini fa parte del Consiglio superiore di Sanità ed è presidente dell'Inran, 'Istituto nazionale di ricerca sugli alimenti e la nutrizione.