

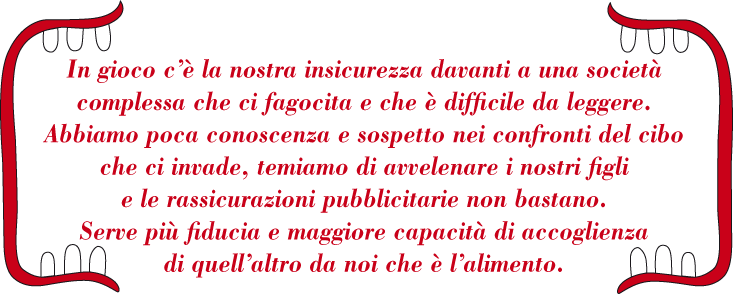
Per la prima volta la nostra società teme il cibo. È sempre più diffusa una mentalità di attenzione, spesso tradotta in sospetti e allarmi, nei confronti del cibo, specie quello di uso quotidiano e che appartiene alla cultura dei nostri padri. Anche la dieta mediterranea tanto osannata appare come un mito per il benessere ma anche fonte di interrogativi sulla reale genuinità dei suoi componenti. Domande del tipo: "Da dove proviene la farina della pasta?" o "Sarà veramente di oliva l'olio che sto utilizzando?" o ancora "La frutta e le verdure che sto gustando da dove provengono o come sono state trattate per averle così perfette o colorate?", condiscono di sospetti o di timori dei 'misteri' racchiusi in un attraente piatto che la dieta definisce adatto per evitare futuri problemi metabolici o cardiovascolari. Al momento di mangiare si fa presente come quella in cui viviamo è anche la prima società ad aver perso visibilità sui processi della catena alimentare.
Cosa sta succedendo? Ne parliamo con Paolo Gentili, psichiatra e docente di Psicologia clinica all'Università 'La Sapienza' di Roma, uno degli esperti di psicologia più vicini al mondo della Diabetologia e alla Associazione Medici Diabetologi in particolare.
Esiste una informazione diffusa, spesso poco controllata ed esagerata, del rapporto tra il nostro corpo e il cibo con cui lo nutriamo. Io so che il cibo può migliorare o peggiorare la mia salute ma non so che cosa esattamente sto mangiando perché non sono coinvolto nella sua origine. Anzi, devo riempire la mente di quelle immagini che offre la pubblicità del prodotto per immaginare campi di grano o botti invecchiate che nella mia vita ho visto solo nei film o nei documentari.
È solo un problema di conoscenza dunque?
No, dietro l'approccio cognitivo alla attuale 'paura del cibo' è possibile sospettare che vi siano delle motivazioni di natura più propriamente psicodinamica. Credo che noi abbiamo paura di essere 'invasi' da ciò che mangiamo: il cibo non è un alleato, anzi uno che mi serve per la mia attività, ma mi entra dentro, sconosciuto e aggressore, veicolando 'cose' che non voglio. Non so bene cosa sia ma ne ho bisogno, desidero che mi aiuti ma ho paura che mi danneggi e quindi mi manipoli.
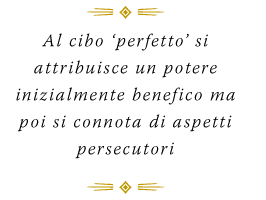 Come se il cibo fosse qualcosa di animato e maligno...
Come se il cibo fosse qualcosa di animato e maligno...
Al cibo 'perfetto' si attribuisce un potere inizialmente benefico ma poi si connota di aspetti persecutori (per quel processo di reificazione, proprio del nostro rapporto profondo con il mondo magico e, in genere, nei confronti di ciò a cui si attribuisce il potere di governare le proprie scelte) specie se associato contemporaneamente a un diffuso scetticismo/timore nei confronti del 'produttore' dell'alimento. Non è così raro che il cibo, quello corretto in quanto documentato e certificato, diventi allora l'estensione di un potere che "mi vuole sano, cioè dipendente" (come l'umanità descritta nella fantascienza sociologica) a cui mi ribello comprando 'cibi genuini' dal 'contadino/macellaio che conosco' o nei mercati o fiere paesane.
Ma cosa c'entra la dipendenza con l'alimentazione delle persone?
Un legame io lo vedo, a parte quello ovvio dei disturbi del comportamento alimentare che qui non ci interessano. In fondo di cosa stiamo parlando? Di una perdita di quel controllo di cui l'uomo è da sempre portatore (come desiderio e come strategia cognitiva). Abbiamo perso il controllo su ciò che mangiamo. E questo coinvolge non solo la salute, il desiderio di benessere ma anche di appartenenza sociale e di conformismo alla 'mentalità comune'. Questo processo è normalmente sfruttato dalla comunicazione sui prodotti alimentari.
Per esempio?
Mangiare è un forte elemento di aggregazione sociale, ha un potere di seduzione forte. Chi non ricorda con nostalgia da giovane il piatto di spaghetti improvvisati a mezzanotte? La colazione fatta tutti insieme con certi prodotti da forno ci fa sentire una famiglia unita, l'amaro rende possibile fare conoscenza con i vicini di tavolo al bar... al cibo si attribuisce il potere di cambiare la nostra vita. Il potere di dare felicità. Il cibo ha il potere di trasformarmi ma questo, se da una parte raccoglie i nostri desideri di sicurezza e di potenza, fa anche nascere inquietudine e timore, al di là della sua pericolosità oggettiva dei suoi componenti. Questo spiega perché gli stessi ambiti sociali dove si diffonde l'attenzione e il timore per ciò che si mangia sono anche gli ambiti che hanno più valorizzato e richiesto la conoscenza del cibo 'buono'. Si diffondono i corsi di sommelier. Oggi, se non sai abbinare un vino a uno specifico piatto, se non conosci almeno un indirizzo 'giusto' di agriturismi o aziende agricole o negozi in cui trovi determinati alimenti, sei irrimediabilmente 'out'. Avere una cultura del cibo è uno status symbol.
Quanto lei dice sull'ambivalenza mi fa pensare al rapporto del neonato con il seno della madre. Secondo diverse teorie il bambino ha paura di essere invaso dal seno almeno quanto ha bisogno del suo nutrimento e del calore.
 L'ipotesi è affascinante. In un certo senso questo spiegherebbe da una parte il timore di essere invasi da un 'seno cattivo' e dall'altra la ricerca affannosa di una 'buona mamma'. Temiamo il cibo 'cattivo' e cerchiamo tutti con angoscia un 'buon fornitore' reale o mitico di cibo. Questo non è più in contatto e quindi verificato dalla propria esperienza reale ma dall''altro', dalla pubblicità, che chiede di essere creduta 'per fede' cioè per quel meccanismo di fiducia che normalmente offre la madre reale al bambino. Il 'seno' materno, che offre al bambino quella esperienza e vissuto di accoglimento, di protezione , di sicurezza necessari per costruire la propria identità, non è più per molti (specie per quelli che vivono in città) una presenza reale (potremmo dire "Vedo e conosco il fornaio da cui acquisto il pane" o "Conosco il contadino da cui acquisto le verdure"). Cerchiamo l'alimentazione da parte di una 'mamma buona' e non ci rendiamo conto che in realtà è 'falsa e cattiva' (cioè essenzialmente interessata ai suoi profitti). Sinceramente non posso confermare questa ipotesi che però mi pare suggestiva di notevoli implicazioni cliniche riguardo per esempio all'attuale malessere del giovane e dell'adulto che manifesta crisi o incertezze sulla propria identità. Nella mia pratica clinica io vedo molte coppie e, soprattutto nelle madri, vedo il rapporto complesso che la donna instaura con il suo essere mamma, rapporto che ovviamente ha il suo centro nel 'dare cibo'.
L'ipotesi è affascinante. In un certo senso questo spiegherebbe da una parte il timore di essere invasi da un 'seno cattivo' e dall'altra la ricerca affannosa di una 'buona mamma'. Temiamo il cibo 'cattivo' e cerchiamo tutti con angoscia un 'buon fornitore' reale o mitico di cibo. Questo non è più in contatto e quindi verificato dalla propria esperienza reale ma dall''altro', dalla pubblicità, che chiede di essere creduta 'per fede' cioè per quel meccanismo di fiducia che normalmente offre la madre reale al bambino. Il 'seno' materno, che offre al bambino quella esperienza e vissuto di accoglimento, di protezione , di sicurezza necessari per costruire la propria identità, non è più per molti (specie per quelli che vivono in città) una presenza reale (potremmo dire "Vedo e conosco il fornaio da cui acquisto il pane" o "Conosco il contadino da cui acquisto le verdure"). Cerchiamo l'alimentazione da parte di una 'mamma buona' e non ci rendiamo conto che in realtà è 'falsa e cattiva' (cioè essenzialmente interessata ai suoi profitti). Sinceramente non posso confermare questa ipotesi che però mi pare suggestiva di notevoli implicazioni cliniche riguardo per esempio all'attuale malessere del giovane e dell'adulto che manifesta crisi o incertezze sulla propria identità. Nella mia pratica clinica io vedo molte coppie e, soprattutto nelle madri, vedo il rapporto complesso che la donna instaura con il suo essere mamma, rapporto che ovviamente ha il suo centro nel 'dare cibo'.
 La madre teme di dare del cibo cattivo...
La madre teme di dare del cibo cattivo...
La mamma confronta il suo dare cibo con l'idea di madre, che nasce dalla mitizzazione della propria madre. "A differenza di mia madre, io acquisto il cibo per mio figlio senza sapere nulla e lo preparo alla bell'è meglio: sono una cattiva mamma", si dice la madre di oggi. Per questo cerca di acquistare alimenti 'speciali' o che le sembrano tali. Ma pensa che non sia abbastanza. Lo mette in tavola facendo finta che sia il meglio, che sia suo.
Mi vengono in mente quelle aziende che negli Usa producono piatti pronti surgelati da mettere in tavola così come sono ma in Europa preferiscono venderne versioni che richiedono ancora una formale 'finitura' da parte di chi cucina.
Esatto. Io madre fingo di aver fatto il meglio. Il bambino - che secondo me ben presto, guardando la televisione 'sgama il gioco' - finge che sia così e la famiglia va avanti. Ovviamente basta il sintomo di una presunta allergia o ancora meno, solo una inappetenza, per scatenare il panico.
"Aiuto!", dice la donna, "sto avvelenando mio figlio!", "Aiuto, il cibo cattivo si è impossessato di mio figlio". Lo stesso avviene per l'uomo, soprattutto quando, come marito, nei giorni di non lavoro o in pensione torna sotto il controllo alimentare della moglie.
A conferma di questa teoria c'è il fatto che queste allergie le vediamo diagnosticate soprattutto nell'età in cui sono ancora sotto il controllo materno. Quando invece i pasti sono scelti da altri, dal figlio stesso o dalla mensa scolastica i problemi si riducono.
Sì, perché in gioco c'è la nostra insicurezza davanti a una società complessa che ci fagocita e che è difficile da leggere. Ora parliamo del cibo, ma la reazione di timore davanti al nuovo riguarda anche altri aspetti. Davanti a un oggetto, a una scoperta la reazione è sempre più spesso "Quanto e come mi farà del male?". Questo è dovuto al fatto che gli oggetti sono misteriosi per me. Da bambini aprivamo le sveglie e, con un po' di attenzione si intuiva il loro funzionamento. Da ragazzi smontavamo i carburatori dei motorini. Oggi lei apre un telefonino e cosa trova? Tante scatolette nere sigillate che contengono circuiti stampati. Parallelamente oggi ci sentiamo più vulnerabili. Non accettiamo tante cose che ieri erano naturali: invecchiare, morire, crescere e... mangiare.
Come uscire da questa situazione? Partecipare alla gestione della propria alimentazione (come oggi si intende fare), salvaguardare le 'autonomie alimentari' (le diete individuate da noi e per noi) a cui ognuno di noi ha diritto e piacere... anche se spesso ce ne rendiamo conto solo il weekend, o al momento della pensione. Speriamo che aumenti la conoscenza di come è - o dovrebbe essere nella realtà - una buona catena alimentare a cui noi attingiamo e la consapevolezza del diritto a rendere 'nostro' il cibo che 'altri' definiscono 'buono' a nostre spese.
E nel frattempo...
 Crescere nella consapevolezza che la paura del cibo può essere affrontata fidandoci delle nostre capacità umane di adattarsi a ogni avversità, sia quelle esterne che quelle che ci entrano dentro. Forse l'obiettivo psicologico di fronte alla paura del cibo come 'nemico' può focalizzarsi in una accettazione meno conflittuale con il cibo ingerito e assimilato. È un problema che vediamo anche a livello di 'corpo sociale': dobbiamo dialogare con lo sconosciuto, passare dall'intolleranza psicofisica all'accoglienza del diverso, anche se un po' misterioso e imperfetto ma sicuramente fondamentale per la nostra vita.
Crescere nella consapevolezza che la paura del cibo può essere affrontata fidandoci delle nostre capacità umane di adattarsi a ogni avversità, sia quelle esterne che quelle che ci entrano dentro. Forse l'obiettivo psicologico di fronte alla paura del cibo come 'nemico' può focalizzarsi in una accettazione meno conflittuale con il cibo ingerito e assimilato. È un problema che vediamo anche a livello di 'corpo sociale': dobbiamo dialogare con lo sconosciuto, passare dall'intolleranza psicofisica all'accoglienza del diverso, anche se un po' misterioso e imperfetto ma sicuramente fondamentale per la nostra vita.
Paolo Gentili
è docente di Psicologia clinica presso il Dipartimento di scienze psichiatriche all'Università La Sapienza di Roma.
Ha parteciopato a numerosi convegni e seminari sull'Educazione terapeutica e sul dialogo fra Team diabetologico e persona con il diabete. Insegna psicologia della coppia e della famiglia presso la Scuola di specializzazione in Psicologia clinica della facoltà di Medicina del medesimo ateneo.